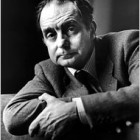Di una vita
 Domani ho la visita di controllo. Ho deciso di avere un punto di riferimento più vicino per la mia salute, quando ho bisogno d’immediatezza, d’urgenza. Ho scelto un medico ospedaliero, di quelli che non hanno grandi ambizioni, che ci sono sempre, che non hanno altro scopo che fare bene il loro mestiere, timbrare il cartellino e tornare a casa dalla loro famiglia. Di quelli che non devono salvare il mondo, che la realtà degli ammalati la vivono nella totale disillusione e non ci sono “le magnifiche sorti e progressive” della Scienza.
Domani ho la visita di controllo. Ho deciso di avere un punto di riferimento più vicino per la mia salute, quando ho bisogno d’immediatezza, d’urgenza. Ho scelto un medico ospedaliero, di quelli che non hanno grandi ambizioni, che ci sono sempre, che non hanno altro scopo che fare bene il loro mestiere, timbrare il cartellino e tornare a casa dalla loro famiglia. Di quelli che non devono salvare il mondo, che la realtà degli ammalati la vivono nella totale disillusione e non ci sono “le magnifiche sorti e progressive” della Scienza.
La neurologa veneta mi ha chiesto, dopo che alla prima visita le avevo portato tanto di quel materiale che avrebbe potuto riempire un intero archivio, di scegliere soltanto gli eventi più significativi e di fotocopiare il tutto perché lo possa inserire in cartella.
Non avrei mai pensato che quest’incombenza mi fosse così dolorosa: quando si sfoglia una cartella clinica è come passare in rassegna la tua vita. Certo, nel diario clinico ci sono soltanto date, farmaci, sintomi, ricadute, nel mio caso ben poche remissioni effettive e infine cortisone, cortisone, cortisone, peggioramenti, peggioramenti, peggioramenti. Ma io riconosco la calligrafia, lo stile, e tutti quei particolari che mancano, quei retroscena, quei ritagli del vissuto che non si leggono, ma basta una data a far riemergere una vita intera.
A rileggere il tutto, mi pare di affrontare la storia di un fallimento, una storia come tante, considerata la cruda verità sulla malattia, ma poiché stavolta è la mia, ho un groppo in gola e gli occhi velati di pianto.
Ogni medico che viene dopo, ha sempre qualche critica da fare a chi viene prima, questo perché non ci sono certezze e ognuno ha la sua teoria che alla fine della fiera porta al medesimo risultato. Mi disse: «il tuo è il classico andamento di una SM con esordio paraparetico». Potevate dirmelo prima, penso, prima di massacrarmi le vene delle braccia, perché se questo è comunque il risultato, mi manca il senso del tempo perduto ad avvelenarmi per sentirvi più utili. I nostri neurologi non si accorgono di quanto si nutrano del puro entusiasmo dei giovani ammalati, consapevoli o meno, e quando, perché il tempo sì, in questo caso, è davvero tiranno, si mette in discussione questo moto a perdere, questo vuoto di significati, allora sei “un paziente difficile”, “un paziente non conforme”. Io sono stata sempre una paziente difficile, anche se ho sempre fatto quanto mi veniva prescritto, perché io quel vuoto lo riempivo, di sentimenti, di umanità, viva e vibrante, ma questo è davvero difficile, perché cercavo un coinvolgimento profondo, un’empatia trasudante tra le crepe che la medicina lascia, molto peggio di un semplice “basta!”.
E se manca questa intelligenza emotiva, come fai a spiegare cosa significa qualità di vita, che un intervento di angioplastica non ti restituirà la vita che sognavi, ma te la cambierà lo stesso, come una brezza marina in un’afosa giornata estiva; eppure continuerai il sacrificio di un’esistenza, quello che ti faceva studiare, attaccata a una flebo, quello che ti fa alzare ogni mattina e zoppicando ti lascia affrontare la giornata. Chiedo sempre troppo, lo so, perché l’amore è troppo, se puoi dare soltanto una ricetta, un colpo di martelletto.
«Sì lo so, non si può fare più niente», dissi, interrompendo la neurologa che mi aveva appena confermato che è meglio non prendere nulla, che ormai sono nella fase progressiva della malattia. «Non niente, non è che non si fa niente, si fanno cose diverse», sostenne allora, quasi per consolarmi. Sorrisi, mi fa ancora tenerezza questo loro spirito dinamico.
La visita ambulatoriale non è il momento più adatto per spiegare il mio percorso, le mie scelte, la dimensione che ho costruito faticosamente, oltre la scienza, oltre la medicina, e un’insofferenza latente verso ciò che considero mediocre.
Sì, sono un paziente difficile. S.C.